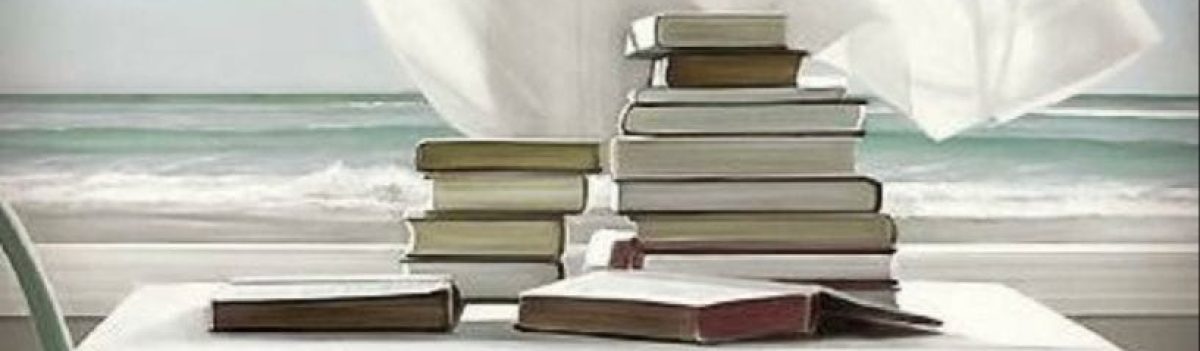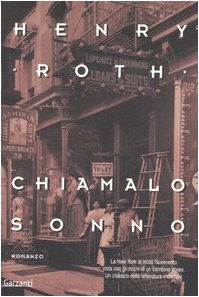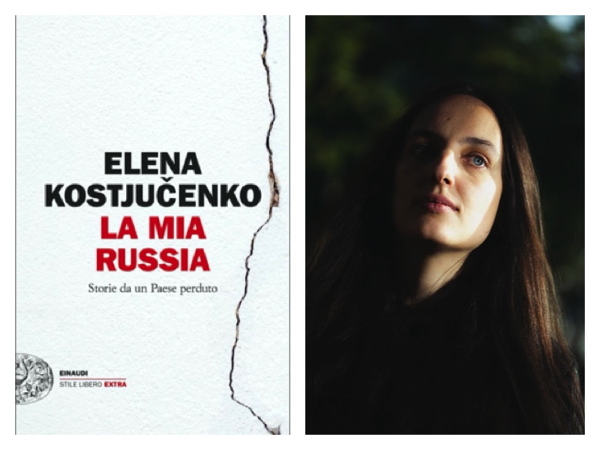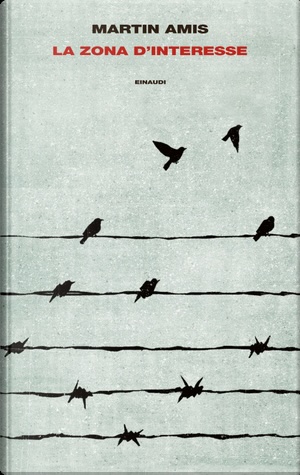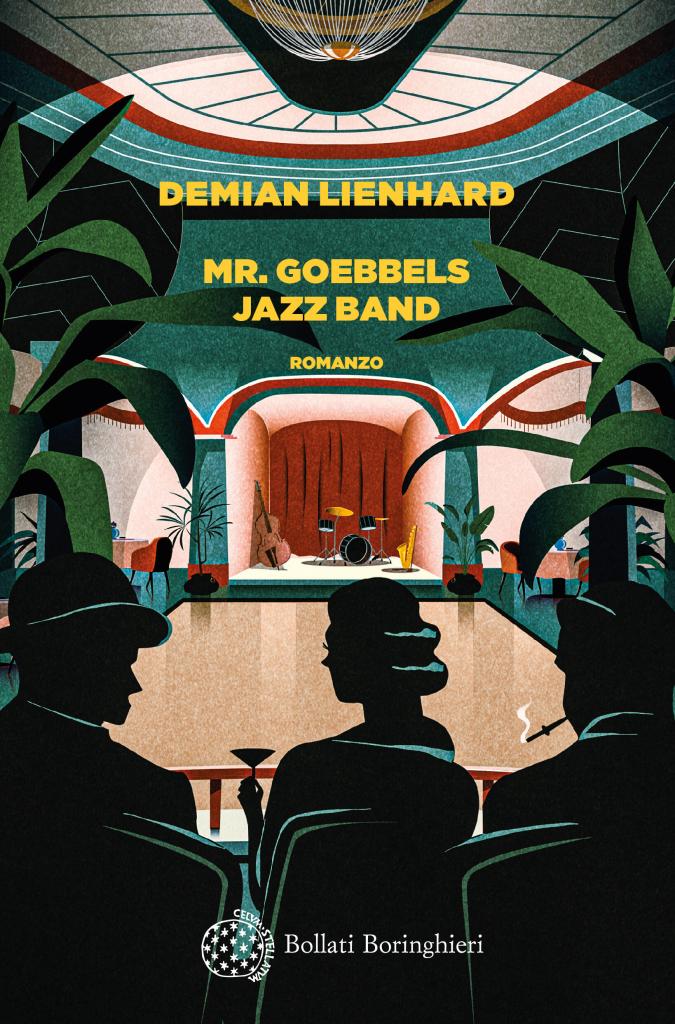“Una levatrice, che aveva appreso la sua arte presso la Divina Casa della Maternità di Parigi sotto la guida della celebre Louise Bourgeois, il 13 gennaio 1622 assistette la gentilissima signora Poquelin, nata Cressé, nel far venire al mondo il suo primogenito, un piccino prematuro di sesso maschile.
Con sicurezza posso affermare che, se avessi avuto l’occasione di spiegare alla venerabile comare chi precisamente stava facendo venire al mondo, questa per l’agitazione avrebbe potuto provocare un qualche danno al piccino e, al tempo stesso, anche alla Francia intera.”
Immediatamente dopo questo primo capoverso della biografia di Molière, ecco entrare in scena (è proprio il caso di esprimersi così) l’autore stesso del libro, Michail Afanas’evič Bulgakov in persona, che si rivolge direttamente alla levatrice in una stanza rischiarata solo dalla luce delle candele, quelle candele che ritroviamo in tante sue opere e che costituiscono uno dei leit motiv ne Il Maestro e Margherita:
Ed eccomi qui: indosso una casacca munita di enormi tasche, e in mano ho una penna, non d’acciaio, ma d’oca. Dinanzi a me ardono candele di cera, e il mio cervello è in fiamme.
“Signora mia, dico, “maneggiate con maggior attenzione il piccino, non scordate che è nato prima del tempo. La morte di questo piccolo significherebbe una perdita immensa per il vostro paese!”
“Mio Dio! La signora Poquelin ne metterà al mondo un altro!”
“La signora Poquelin non ne potrà mai più mettere al mondo uno così, e nemmeno nessun’altra signora, nel corso di alcuni secoli, ne metterà al mondo uno simile.
”Voi mi stupite, signore!”
“E io stesso ne sono stupito. Cercate di capire che, trascorsi tre secoli, in un paese lontano, io mi ricorderò di voi solo perché avete tenuto in braccio il figlio del signor Poquelin.”
“Ho tenuto in braccio dei piccoli ben più illustri.”
“Cosa intendete, voi, con la parola ‘illustri’? Questo piccino diventerà più famoso del re che adesso vi governa, del vostro Luigi XIII, diventerà più noto del re successivo, e quel re, signora mia, si chiamerà Luigi il Grande, o Re Sole! Buona signora, esiste un paese [selvaggio, voi non lo conoscete, è la Moscovia, un paese freddo e terribile. Lì non ci sono i lumi e l’istruzione, ed è popolato da barbari] che parlano una lingua strana per il vostro orecchio. Ecco, dunque, persino in quel paese in breve s’intrufoleranno le parole di colui che avete appena aiutato a venire al mondo.”
In questo bellissimo incipit sono presenti praticamente tutti gli elementi fondamentali che caratterizzano questo libro: il dialogo diretto tra Bulgakov e Molière ed altri personaggi, la sua grandissima ammirazione ed empatia per l’artista francese, la sottolineatura delle differenze esistenti tra il mondo culturale francese e quel “mondo lontano”, quel paese “freddo e terribile” in cui sono assenti “i lumi dell’istruzione” ed è “popolato da barbari”.
Ed infine, dettaglio molto, molto importante e prezioso, in questa edizione finalmente integrale del libro (ci sono voluti ben quarant’anni dalla morte del suo autore, per averla!) la presenza delle parentesi quadre (che io ho evidenziato in grassetto) che indicano tutte le frasi e le parti eliminate dalla censura sovietica nella prima pubblicazione del romanzo avvenuta nel 1962…Quante cose dell’URSS stalinista e della ferrea attività censoria degli anni ’30 rivelano quei brani racchiusi da parentesi quadre!
Continua a leggere “VITA DEL SIGNOR DE MOLIÈRE – MICHAIL BULGAKOV”