 Tra gli scrittori che mi interessano in questo periodo c’è Anna Banti. Perciò, dopo aver parlato di Artemisia, eccomi qui con La camicia bruciata.
Tra gli scrittori che mi interessano in questo periodo c’è Anna Banti. Perciò, dopo aver parlato di Artemisia, eccomi qui con La camicia bruciata.
Pubblicato nel 1973, La camicia bruciata è — almeno in parte — la biografia romanzata di Marguerite Louise d’Orleans, cugina di Luigi XIV data in sposa (sarebbe più corretto dire “malmaritata”) a Cosimo III dei Medici. Il libro è posteriore di circa trent’anni alla pubblicazione di Artemisia (1947).
Tra i due romanzi ci sono analogie fin troppo evidenti che balzano subito agli occhi: anche qui la storia di una donna, anche qui, almeno per circa metà del volume, un impianto narrativo costituito da un dialogo tra l’autrice e il suo personaggio. Anche qui, una figura femminile che in qualche modo cerca, attraverso i secoli, di far sentire la propria voce e far valere le proprie ragioni.
Ma a mio modo di vedere sono analogie solo di superficie, perchè La camicia bruciata è, in realtà, profondamente diverso da Artemisia. Per la genesi dell’opera, per l’atteggiamento dell’autrice nei confronti del suo personaggio, per il giudizio che, implicitamente ma a tratti anche esplicitamente la Banti dà di Marguerite Louise.
Prendiamo innanzitutto il modo in cui Anna Banti si trovò a decidere di scrivere proprio su Marguerite Louise. Ce lo racconta lei stessa nella nota introduttiva al libro intitolata “Perchè”.
In essa infatti la Banti ci dice che l’idea le venne inizialmente suggerita da Emilio Cecchi che “con quel suo risolino in punta di labbra, a occhi socchiusi” le disse un giorno “Perchè non la racconta lei, la storia di Marguerite Louise?”. Ma lei era molto poco interessata al soggetto e la cosa finì lì. Fino al giorno in cui, consultando per altri motivi gli Archivi Medicei “la figura bislacca della sposa di Cosimo III suscitò la mia — assai scettica, peraltro, curiosità […] ebbi l’impressione che se ne dicessero troppo e troppo marchiane su questa “Fille de France” importata a Firenze. Era proprio così corrotta e proterva come riferivano le cronache?”.
La Banti chiarisce molto bene, in questa nota introduttiva, di essere stata “lontanissima dal desiderio di riabilitarne la memoria” e che ciò che l’aveva spinta alla scrittura era stato il desiderio di “considerarne le malefatte con criteri un po’ più obiettivamente aggiornati”.
E infatti la scrittrice non è affatto tenera con Marguerite Louise, tutt’altro. A cominciare dal celebre incipit:
“Non parla, ronza, sibila, punge. Non vede la finestra aperta, sbatte sui vetri. Qui c’è sangue da succhiare, fuori la luce dove tutto dilegua le è nemica. Aspetta il buio per abbassarsi a volo radente, minimo vampiro protetto da un nome, Marguerite Louise: il guscio dove si crede ancora una principessa”
Con questa manciata di righe Marguerite fa dunque la sua entrata sulla scena del romanzo tratteggiata come una zanzara, una parassita, una succhiasangue, una vampira. Che si agita a casaccio e che per questo non è in grado di valutare gli ostacoli che ha di fronte. Una che non è niente ma si crede chissà che cosa. Che se non fosse “protetta” dal nome che porta e dalla parentela che la lega al Re Sole nessuno prenderebbe in considerazione.
E non finisce qua. Lo scambio di battute tra l’autrice ed il suo personaggio, più che un dialogo ed uno scambio alla pari tra persone che si stimano (come era in Artemisia) qua somiglia di più ad un processo. Il tono della Banti sembra più quello di un Pubblico Ministero. Marguerite viene accusata di atteggiarsi ad “attrice che declama”, il contesto in cui si muove è un “teatrino”, le persone di cui si circonda “servi di scena”. “Spogliatevi dei vostri orpelli e lasciatevi inventare con qualche verisimiglianza”, le intima la Banti a pag.38.
Marguerite Louise pensa solo a se stessa, non ama nessuno, nemmeno i suoi tre figli che abbandona a Firenze per sempre senza rimpianti pur di tornarsene in Francia. “Vous n’aimez personne, Mademoiselle”, la ammoniva Madame de Rairé, la sua prima governante, il faut vous corriger” (p.107). L’anaffettività è uno dei suoi caratteri distintivi.
“L’amour, diceva, mi manca l’amore […] lei lo intendeva in modo curioso, avrebbe voluto essere adorata senza ricambio […] era difficile volerle bene […] le persone che l’avvicinavano, uomini e donne, dovevano comportarsi nel modo che lei, nella sua testa, aveva stabilito”. Sono queste le parole che la Banti mette in bocca a Cintia, la serva cantatrice e violinista che rimane al fianco di Marguerite per anni, prima a Firenze e poi a Parigi.
Ma a poco a poco “il teatrino crolla”, autrice e personaggio non dialogano più. Marguerite esce di scena, diventa personaggio assente. La voce narrante in terza persona diventa unica e stabile. Avanzano e conquistano il primo piano altre figure femminili. Anna Ludovica, figlia di Marguerite e di Cosimo rimasta vedova dell’Elettore di Baviera tornerà in Firenze e alla morte del padre e del Gran Principe Ferdinando suo fratello prenderà il potere. Sarà l’ultima discendente dei Medici. Violante Beatrice di Baviera, moglie di Ferdinando (e dunque nuora di Marguerite) che, rimasta anch’essa vedova, governerà per tre anni Siena dimostrandosi contro ogni aspettativa donna capacissima di gestire e di amministrare la cosa pubblica e sarà molto amata dai suoi sudditi.
Toccherà proprio a Violante scoprire a Siena alcuni documenti (tra i quali uno del celebre scienziato e scrittore Magalotti) che documentano le calunnie diffuse su Marguerite Louise dal bigottismo dei Medici.
Ma se i Medici hanno sicuramente enfatizzato se non addirittura inventato molti degli atti attribuiti a Marguerite Louise il cui comportamento nell’ottica di una morale più moderna può risultare tranquillamente ridimensionato, non per questo, a mio parere, il giudizio complessivo della Banti è molto lusinghiero, nei confronti di Marguerite.
La morale secentesca avrà pure esagerato, con lei, ma quello che Anna Banti scrive a pag. 48 non mi par proprio vada molto sul leggero : “…dalla prima adolescenza. Fin da allora eravate, malgrado le fantasticherie romanzesche, bene attenta ai vostri interessi: oggi vi si attaglierebbe il ruolo di una dattilografa americana divenuta padrona di pozzi di petrolio, pluridivorziata, lagnosa e tirannica”.
E, tornando alla nota introduttiva, leggiamo: “In fondo, questa cugina del Re Sole mi risultava, malgrado l’evidenza del suo rango, altrettanto sconosciuta di una qualunque borghesuccia attuale che si butta dalla finestra, va a sapere perchè.” Aggiungendo più avanti “alla fine conclusi che se proprio insistevo ad occuparmene […] dovevo reinventarla”.
In una intervista, la Banti dice che i suoi romanzi sono “interpretazioni storiche” piuttosto che “romanzi storici”. Per come la vedo io, la Marguerite che emerge dalla “interpretazione storica” della Banti non è che sia granchè meglio, mi pare, di quella figura di Gran Corruttrice che i Medici tendevano ad accreditare: la Marguerite bantiana è una femminetta noiosamente “lagnosa e tirannica” i cui capricci risultano oltre che inutili anche autodistruttivi, incapace di amare, incapace di essere realmente trasgressiva.
… Sbaglierò ma io ho chiuso il libro convinta che le figure femminili di Anna Ludovica e Violante Beatrice di Baviera — con tutti i loro difetti e i loro problemi — stavano molto più simpatiche di Marguerite, alla Banti. Perchè si tratta di figure discutibili quanto si vuole ma, ciascuna con le proprie modalità, figure di donne forti che sono riuscite ad utilizzare tutti gli spazi concessi dai rigidissimi vincoli imposti a tutte le donne del loro tempo in generale e quelli imposti alle donne della loro condizione sociale in particolare.
La “ribelle” Marguerite, con il suo esibizionismo e tutta la sua smania di libertà, non ottiene come risultato, alla fine, che di vivere come prigioniera in un convento e di morire “sola e dimenticata”. Le “obbedientissime” Anna Ludovica e Violante Beatrice riescono, al contrario, la prima (l’Elettrice Palatina) ad arrivare al governo del Granducato di Toscana e a lasciare un segno nella storia diventando una delle figure medicee ancora oggi più apprezzate e la seconda (Violante) lascia il governatorato di Siena “compianta e rimpianta”, con “modi del congedo sereni e controllati”, con un “sorriso timido” ed occhi “teneri, larghi e limpidi”.
Nota a proposito del libro: La camicia bruciata è un testo non più reperibile nelle normali librerie. Se si è molto fortunati lo si può forse trovare in qualche bancarella o nelle librerie di antiquariato. La copia che ho io è una vecchia edizione Mondadori – De Agostini del 1987, collana “‘900 – Capolavori della narrativa contemporanea”. Note introduttive di Attilio Cannella.
Altri punti di vista (anche molto diversi dal mio) su La camicia bruciata:
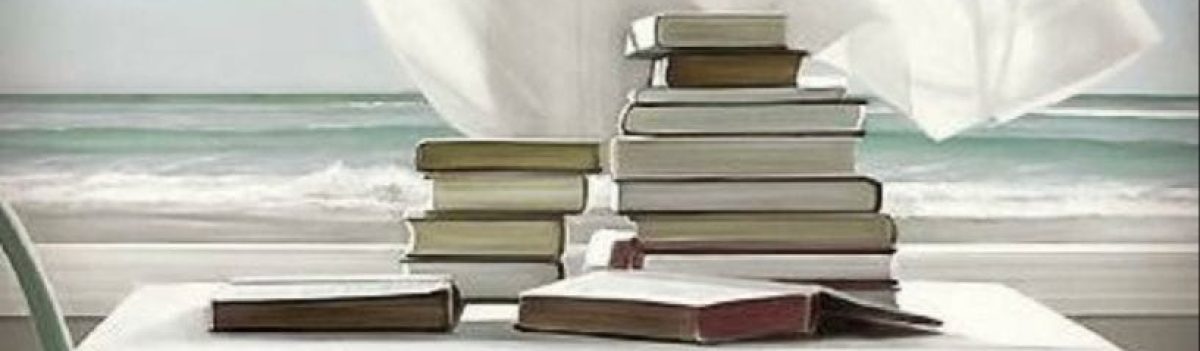
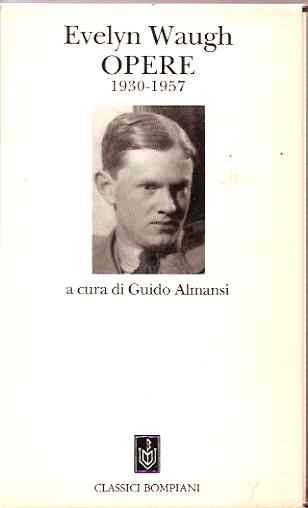


 Tra gli scrittori che mi interessano in questo periodo c’è Anna Banti. Perciò, dopo aver parlato di
Tra gli scrittori che mi interessano in questo periodo c’è Anna Banti. Perciò, dopo aver parlato di 


