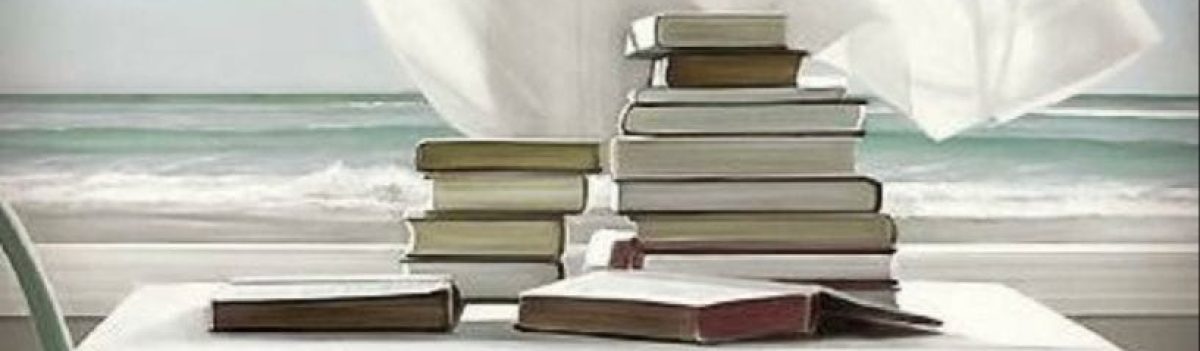Magda SZABÓ, La notte dell’uccisione del maiale (tit. orig. Disznótor), traduz. dall’ungherese di Francesca Ciccariello, A cura di Mónika Szilágyi, ed. Anfora, p.220, 2011
Debrecen, una cittadina di provincia dell’Ungheria.
Anni ’50.
In un freddo giorno invernale, una famiglia si prepara — come recita la quarta di copertina — all’annuale uccisione del maiale ed al conseguente banchetto.
Questo romanzo, scritto da una quarantasettenne Magda Szabó nel 1960 e cioè negli anni in cui l’Ungheria era sotto il regime fiolosovietico viene oggi reso disponibile per i lettori italiani grazie alla casa editrice Anfora, che della grande scrittrice ungherese ha curato la pubblicazione di altri libri.
Tra questi, voglio ricordare adesso Per Elisa che, essendo la prima parte dell’autobiografia della Szabó — rimasta purtroppo incompiuta a causa della sua morte avvenuta nel 2007 — risulta di molto aiuto, oggi, per comprendere meglio questo La notte dell’uccisione del maiale.
Sulla scena del romanzo vediamo muoversi (e scontrarsi) due famiglie: la famiglia Tóth, i cui membri sono chiamati “i saponieri” perchè da almeno tre generazioni si dedicano appunto alla fabbricazione ed alla vendita del sapone e la famiglia Kémery, nobili ex latifondisti che, sebbene ormai decaduti ed ai quali il regime ha requisito anche l’ultimo bene immobile da loro posseduto, e cioè il palazzo avito, non avendo per questo perso la loro boria e la loro superbia trattano sprezzantemente tutto il resto del mondo.
All’inizio del romanzo apprendiamo che János Tóth (il primogenito della famiglia dei “saponieri”) è, da più di vent’anni, marito di Paula Kémery.
Per motivi diversi ma complementari, questo matrimonio non è stato mai perdonato né dai “saponieri”, che hanno visto in questo un vero e proprio tradimento delle tradizioni familiari da parte del primogenito né dai nobili Kémery che — sebbene spiantati — non hanno mai smesso di disprezzare János e di trattarlo come un essere a loro inferiore e di cui vergognarsi nonostante egli sia da anni un maestro di scuola molto stimato da superiori e colleghi ed amato dai suoi alunni
Il romanzo si svolge tutto a Debrecen — che, detto tra parentesi, era anche il luogo di nascita della stessa Szabó che a Debrecen visse ed insegnò anche, per molti anni — nell’arco temporale di sole 24 ore.
Attraverso una serie di capitoli ciascuno dei quali centrato su uno dei numerosi personaggi guardato dal punto di vista di un altro ed attraverso un vero e proprio gioco di specchi in cui si riflette il modo in cui ciascuno considera sè stesso e viene percepito dagli altri, in un continuo intrecciarsi di piani temporali e oscillazione tra presente e passato vediamo a poco a poco delinearsi con chiarezza uno scenario che, se all’inizio ci appariva confuso e nebuloso e difficile da comprendere, diventa via via sempre più inquietante.
Come in puzzle, come dalla tessitura di un arazzo, la figura, “l’intreccio” prende forma.
I buchi cognitivi che ci avevano resa all’inizio poco comprensibile e a tratti difficile la lettura vengono colmati. Diventano comprensibili ed, acquistando senso, la figura che si delinea sotto gli occhi di noi che leggiamo assume contorni sempre più drammatici.
Lo scenario che si delinea è uno scenario in cui il succedersi degli eventi, di piccoli gesti solo apparentemente banali ed insigificanti, delle riflessioni e dei ricordi dei singoli personaggi ci fa presto avvertire in modo sempre più incalzante l’approssimarsi della tragedia.
Il romanzo si chiude con un bellissimo e catartico finale, a proposito del quale ovviamente non anticipo nulla.
Ho adoperato non a caso termini come “scena”, “scenario”, “tragedia” e “catarsi” perchè quello che ci offre Magda Szabó è proprio la rivisitazione — per mezzo di una struttura e di una strategia narrativa molto moderna — dell’antica tragedia greca.
Dell’antica tragedia greca La notte dell’uccisione del maiale ha non solo le caratteristiche formali dell’applicazione delle tre classiche unità aristoteliche (unità di tempo, luogo e azione) ma soprattutto il senso — di cui il lettore acquista pagina dopo pagina sempre maggiore consapevolezza — della inelutabilità degli eventi, della tragicità degli effetti che possono derivare da micro-episodi apparentemente banali.
Un gesto compiuto generosamente e con le migliori intenzioni, per esempio può rivelarsi (come spesso succede nei romanzi della Szabó) distruttivo, mentre la catastrofe (nel senso strettamente etimologco del termine) può venire da una scoperta casuale, dalla percezione distorta di un gesto, una parola, uno sguardo dell’altro.
Nella struttura e nello stile di scrittura (molto colto e raffinato) del romanzo ritroviamo il gusto, la conoscenza, la passione che Magda Szabó nutriva sin da bambina per il mondo della cultura classica e della tragedia greca e che abbiamo imparato a conoscere proprio da quello che lei stessa ci ha raccontato in Per Elisa.
Magda Szabó però non sarebbe la grande scrittrice che è se fosse rimasta congelata dentro antiche formule; scrittrice del suo tempo, risulta modernissima nell’uso sapiente, ad esempio, della tecnica della molteplicità dei “punti di vista”.
Un uso che lo stesso Henry James, considerato l’inventore di questa tecnica per quanto riguarda la letteratura occidentale sono sicura avrebbe non solo apprezzato ma invidiato.
Romanzo molto duro, ne La notte dell’uccisione del maiale nessun personaggio è completamente innocente o completamente vittima.
Tutti hanno qualcosa da rimproverare agli altri ma anche colpe di cui doversi vergognare, nessuno risulta simpatico o antipatico senza se e senza ma; il libro è un romanzo di amore e di morte, ma anche, in qualche modo, di resurrezione.
E’ un libro che fa venir voglia — giunti all’ultima pagina — di ricominciare dall’inzio. Perchè una volta terminato ci rendiamo conto, improvvisamente, che tutto il dramma era contenuto già nel primo paragrafo e che la Szabó aveva disseminato nel corso della narrazione decine di indizi che soltanto giunti alla fine noi lettori siamo in grado di “vedere” e decodificare.
Se il romanzo, proprio come una tragedia greca, ha un protagonista e un deuteragonista, è anche vero però che in esso nessun personaggio può dirsi davvero secondario o marginale: ciascuno ha una sua precisa collocazione, necessità di esserci, funzione.
E siccome i personaggi sono parecchi, e siccome per noi lettori italiani non è certo facilissimo memorizzare nomi e cognomi ungheresi (cui si aggiungono vezzeggiativi, diminutivi e nomignoli) personalmente ho apprezzato enormemente il fatto che proprio all’inizio del libro la curatrice Mónika Szilágyi abbia inserito un dettagliato elenco dei personaggi completo di dati anagrafici e soprattutto dei legami di parentela che intercorrono tra di essi.
La prime venti, trenta pagine del romanzo sono già — per precisa scelta narrativa della Szabó — abbastanza ardue da comprendere, e personalmente non so come sarei riuscita a superarle senza il supporto di questo elenco.