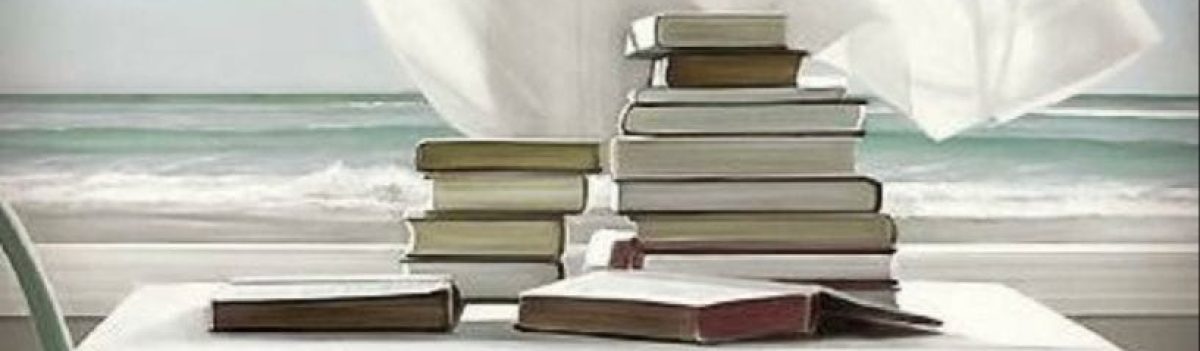“Ho conosciuto il grado e la forma più alta della libertà individuale, per vederla poi al più basso livello cui sia scesa da secoli; sono stato festeggiato e perseguitato, libero e legato, ricco e povero”
“Come austriaco, come ebreo, come scrittore, quale umanista e pacifista, mi sono di volta in volta trovato là dove le scosse erano più violente. Esse per tre volte hanno distrutto la mia casa e trasformata la mia esistenza, staccandomi da ogni passato e scagliandomi con la loro drammatica veemenza nel vuoto, in quel “dove andrò?” a me già ben noto. Ma non lo voglio deplorare, giacchè appunto il senzapatria ritrova una nuova libertà, e solo chi non è più a nulla legato non ha più bisogno di aver riguardo per nulla.”

Ho letto in questi giorni Mendel dei libri e Novella degli scacchi di Zweig, di cui conoscevo, per averlo letto tanti anni fa, soltanto Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo e di cui avevo un buon ricordo. L’ho dunque ripreso in mano.
Sempre più spesso mi succede di rileggere vecchi libri e di interessarmi all’opera di un autore nel suo complesso; sempre più mi interessa cercare di cogliere le connessioni tra un testo ed un altro, affinità e differenze fra vari autori. Per questo torno spesso su libri e scrittori di cui ho già parlato, e magari anche più di una volta. Sempre meno mi interessa “macinare” libri per la serie “finito, avanti il prossimo”, sempre più preferisco la lentezza che la velocità, nella lettura.
Nato a Vienna nel 1881 da una ricca famiglia ebraica, Zweig si laureò in filosofia nel 1904. Appassionato viaggiatore, ebbe modo di conoscere numerosi luoghi del mondo e di incontrare alcuni tra i più importanti esponenti della società e della cultura del tempo: Hofmannsthal, Rilke, Romain Rolland, G. B. Shaw, Rathenau, Auguste Rodin, Hermann Hesse, James Joyce, Ferruccio Busoni… Europeista, cosmopolita, pacifista convinto, fu un autore molto prolifico ed eclettico. Scrisse molte biografie, romanzi, novelle, si occupò di traduzioni, era un appassionato collezionista di autografi di scrittori e musicisti.
Cresciuto nella Vienna di Gustav Mahler, grande amico dei più importanti musicisti del suo tempo, scrisse saggi su Handel e Toscanini e fu anche librettista d’opera: scrisse infatti il libretto dell’opera di Richard Strauss Die schweigsame Frau — La donna silenziosa. La storia della prima rappresentazione dell’opera di questa strana coppia (l’ebreo e il filonazista nell’Austria ormai hitleriana) meriterebbe da sola un post.
Negli anni tra le due guerre mondiali Zweig era pubblicato e letto in tutto il mondo, in tutte le lingue. I suoi libri avevano milioni di lettori. Oggi è un autore piuttosto trascurato, in italiano non si trova molto ed alcune tra le sue più celebri biografie sono fuori catalogo.
Nel 1934 l’ebreo Zweig riuscì a fuggire in tempo dall’ Austria per spostarsi in Inghilterra e nel 1940 si trasferì definitivamente negli USA come tanti altri esuli ebrei.
Il mondo di ieri è la sua autobiografia. Troppo spesso, a mio parere, quando questo libro viene ricordato, si parla di Zweig un po’ troppo sbrigativamente come di un nostalgico del bel tempo che fu, lo si definisce “il cantore della Felix Austria“, lo si considera come una persona irrimediabilmente ancorata al passato.
Nella sua autobiografia troviamo, certo, la nostalgia.
Come può non rimpiangere il mondo della giovinezza una persona alla quale due guerre mondiali e soprattutto l’avvento del nazismo hanno stravolto completamente la vita, che ha visto i suoi libri ardere nei roghi nazisti, che per salvarsi la vita è costretto a fuggire prima dall’Austria e poi dall’Europa perdendo non solo tutti i beni materiali come casa e mobili ma anche la biblioteca, le sue amate collezioni di autografi, gran parte dei manoscritti e soprattutto il passaporto venendo dunque, in quanto apolide, privato di qualunque diritto di cittadinanza e di appartenenza?
Però nel libro — scritto in una prosa limpida e scorrevolissima — non troviamo solo nostalgia, rimpianto, recriminazione. C’è anche un’analisi molto acuta, lucida e sottile dei fenomeni e delle cause che determinarono il passaggio dalla monarchia absburgica ai tremendi anni che seguirono. La descrizione dell’Austria degli Absburgo (“il mondo della sicurezza”) contiene anche l’indagine spregiudicata di alcune piaghe sociali e particolarmente interessante l’analisi degli elementi che determinarono le diverse reazioni della gente comune allo scoppiare della prima e della seconda guerra mondiale.
Claudio Magris, nel saggio Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna definisce Zweig “classico esponente del vago cosmopolitismo umanitaristico sorto nella civiltà absburgica”, lo definisce scrittore “superficiale”, “umanista in ritardo e fuori tempo, simpatica e cordiale personalità inadeguata ai problemi della sua epoca” e scrive che “Zweig resta come la nobile, cara e vana voce di una protesta morale contro la crudele ruota delle cose, simile al suo Erasmo da Rotterdam con il quale s’era identificato) (*)
Carlo Emilio Gadda, poi, è spietato. Proprio a proposito di Il mondo di ieri scrive nel ’45: “Un trufolone europeo che va in cerca di tutti, è amico e ospite di tutti, è stato a balia con tutti […] Tutto ciò non gli impedisce di “nutrire degli ideali”. Il più alto, il più generoso, ed ad un tempo il più facile, è la comunione delle anime universe nella civiltà della supernazione. Auspicio supremo: la scomparsa dei passaporti.” (**)
Un giudizio — e lo dico con tutto il rispetto e la stima che ho per Gadda — ferocemente ingeneroso.
Intendiamoci: Zweig non è certo un autore che possa competere con un Musil. Non è un innovatore, un rivoluzionario della scrittura. E’ volto più al passato che al futuro. E’ sostanzialmente un conservatore. Ma ci sono scrittori che pur non avendo forse titolo per entrare nel Pantheon dei Grandi meritano comunque di esser letti e ricordati. Zweig è secondo me, decisamente, uno di questi. La sua scrittura è piacevolissima, elegante, fluida e paradossalmente, proprio autori come lui, così legati al loro tempo sono testimoni preziosi. La conoscenza di questi scrittori non potrebbe che essere utile, alle giovani generazioni.
La stesura di Il mondo di ieri venne completata nel 1942 a Petropolis, cittadina a nord di Rio de Janeiro in Brasile.
Il 22 febbraio del 1942 Stefan Zweig morì suicida assieme alla seconda moglie Lotte Altmann.
L’ autobiografia venne pubblicata per la prima volta a Stoccolma due anni dopo nel ’44.
Sui veri motivi del suicidio sono state fatte moltissime ipotesi.
Nel suo libro Zweig torna più volte sul tema di “quell’orribile condizione dell’essere senza patria, impossibile a spiegarsi a chi non l’abbia provata su sè medesimo, quel senso esasperante di procedere ad occhi aperti nel vuoto, sapendo che dovunque si appoggi il piede, ad ogni istante si può essere ricacciati indietro”.
Molti altri artisti e letterati hanno avuto esperienze simili a quelle di Zweig: la perdita di tutto, l’esilio, il piombare da un “mondo della sicurezza” a quello della costante insicurezza. Ciascuno di loro ha reagito come sapeva e come poteva. Alcuni sono riusciti a gettarsi alle spalle il passato e ricominciare tutto daccapo. Altri non ce l’hanno fatta, e si sono tolti una vita che per loro non era più vita.
Nessuno ha il diritto di giudicare.
===============
(*) Claudio Magris, Franz Werfel e Stefan Zweig, in Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna, Einaudi Reprints, 1976, p.293)
(**) L’opinione di Gadda è riportata da Daniele Del Giudice nella prefazione a Stefan Zweig, Novella degli scacchi, Garzanti Gli Elefanti, 2007, p. 12.