
Daniel MENDELSOHN, Gli scomparsi (Tit. orig. The Lost. A search for six of six million), traduz. di Giuseppe Costigliana, p.722, Neri Pozza, Collana Bloom, 2007, ISBN 9788854502253
Daniel Mendelsohn è un ebreo laico americano appartenente alla terza generazione di una famiglia di ebrei provenienti da Bolechow, (oggi Bolekhiv) —- uno stethl dell’Europa orientale (Galizia) passato dall’impero austro ungarico ai polacchi, poi ai sovietici ed infine all’Ucraina — riusciti ad emigrare negli Stati Uniti appena in tempo prima dell’inizio della Shoah.
Insegna greco antico a New York.
Proprio così: colui che si potrebbe immaginare ossessionato dall’Europa centrale lacerata nel corso dei secoli tra L’Austria-Ungheria, la Germania, la Polonia, l’Ucraina e la Russia, è in realtà un appassionato dell’antica Grecia, della mitologia, dei grandi classici latini e greci.
Lui stesso, in un’intervista, ha spiegato le ragioni di questo amore dicendo: “Io sono ebreo ed omosessuale. La componente ebrea, in me, è la componente della tradizione della famiglia, del dovere. La componente greca, pagana, è quella del desiderio e del piacere”.
Articoli e saggi di Mendelsohn compaiono sul New Yorker, sul New York Times Book Review, sull’ Esquire e Paris Review e in volumi antologici. Gli scomparsi non è il suo primo libro: prima di questo, nel 2001 aveva pubblicato The Elusive Embrace: Desire and the Riddle of Identity”, che era stato premiato come libro dell’anno dal New York Times e dal Los Angeles Times.
Questo libro è il risultato della ricerca personale che Daniel Mendelsohn ha condotto per far luce sul destino di alcuni membri della sua famiglia scomparsi nell’Olocausto.
Com’è nato Gli scomparsi? Fin da bambino, Daniel Mendelsohn si appassiona alla storia della famiglia, ricostruisce l’intricatissimo albero genealogico, ascolta le storie che gli racconta il nonno: a poco a poco riesce a delineare il quadro dell’ascendenza familiare risalendo per tre o quattro generazioni. Ma si accorge che ci sono alcune persone di cui non si parla mai, a proposito delle quali il nonno, di solito tanto loquace e generoso di aneddoti di ogni genere, diventa improvvisamente muto: si tratta del prozio Schmiel (fratello del nonno) e della sua famiglia.
Di lui viene a sapere soltanto che non è riuscito ad arrivare in America, che è rimasto a Bolechlow con la moglie e le sue “quattro bellissime figlie” e che tutti loro sono stati “uccisi dai nazisti” nel 1941.
Ma quando, esattamente? E dove? E come? Ogni volta che Daniel formula queste domande, tutti i parenti tacciono. Dello zio Schmiel e della sua famiglia nessuno vuole parlare.
Daniel però ricorda che, quando era un bimbetto di sei-otto anni, tutte le volte che entrava in una stanza in cui c’erano dei parenti ebrei, questi scoppiavano in lacrime ed esclamavano: “Oh, come assomiglia a Schmiel!”
Alla morte dell’amato nonno, Daniel scopre le lettere che Schmiel aveva inviato nel 1939 a suo fratello già negli Stati Uniti. La lettura di queste lettere lo spinge ad una ricerca che in un primo tempo realizza sulle carte di famiglia e utilizzando tutte le risorse che oggi Internet offre, ma che in una seconda fase svolgerà “sul campo”, andando in cerca di persona (accompagnato dal fratello minore Matt, eccellente fotografo) della manciata di sopravvissuti allo sterminio degli ebrei di Bolechow ancora viventi e che si trovano sparpagliati dall’Australia a Israele, dall’Olanda all’Austria.
Spera, attraverso i loro ricordi e le loro testimonianze, di ricostruire la storia dei suoi scomparsi.
In effetti, quello di cui Daniel si rende conto, man mano che la sua ricerca procede, è che con lo sterminio di tutta la popolazione ebrea di Bolechow non solo lo zio Schmiel e la sua famiglia sono “perduti” (“lost”, è il titolo originale inglese), ma è tutto un mondo, che è andato perduto, un mondo e la sua cultura e, in parte, anche la sua lingua.
tutto un mondo, che è andato perduto, un mondo e la sua cultura e, in parte, anche la sua lingua.
Il racconto di Mendelsohn è commovente, talvolta persino divertente, costruito come un giallo. E’ un “Alla ricerca di un passato familiare perduto” che evoca l’opera di Proust, che lo scrittore ha riletto attentamente prima di immergersi nella realizzazione di questo testo.
Ebreo di terza generazione, l’ultima ad avere la possibilità di contattare sopravvissuti della Shoah, Daniel Mendelsohn realizza un vero capolavoro, una testimonianza dell’indicibile in lotta con i tabu di questo periodo storico.
Il suo non è però un ennesimo libro sulla Shoah.
E’ innanzitutto un’opera letteraria, che cerca di dare una risposta ad una domanda fondamentale, per uno scrittore: come scrivere di un passato che non si è conosciuto? Cosa possiamo sapere del destino di uomini e donne svanito da così tanto tempo?
Mendelsohn parte dunque per un viaggio nella “terra dei padri”, va a Bolechow in cui la popolazione (diecimila abitanti circa), prima della guerra era composta per un terzo da ebrei, un terzo da ucraini ed un terzo da polacchi. Dopo la guerra, di ebrei ne erano rimasti solo 48…
Il viaggio è deludente, Mendelsohn non apprende che banalità, del genere “tre culture che coabitavano bene”, etc.
Torna in America ed ecco, qualche mese dopo, il punto di svolta.
Una sera squilla il telefono. E’ un sopravvissuto di Bolechow che chiama dall’Australia: “… lei non mi conosce, ma io ho saputo che cerca notizie su Bolechow. Io posso esserle utile”. Inizia così per Daniel Mendelsohn, questo specialista di culture antiche, una Odissea che da New York lo porta in Australia, Praga, Tel Aviv, Vilnius; dalla Svezia a Vienna, e poi ancora in Danimarca e di nuovo, infine, in Ucraina…
Un’odissea in cui a poco a poco comincia a pensare di essere “alla ricerca della storia sbagliata — la storia del modo in cui sono morti, piuttosto che quella del modo in cui sono vissuti”.
Mendelsohn non vuole parlare di morti.
Tenta di restituire, a Schmiel ed alla sua famiglia, una vita che è stata loro rubata, un’umanità fatta di dettagli di vita quotidiana, quella che fu la “loro” vita. Il viaggio deve servire a salvare i suoi parenti “dalle generalizzazioni, dai simboli, per render loro la loro individualità”, a “riportare in vita gli scomparsi” (p.287).
Le testimonianze dei dodici sopravvissuti allo sterminio degli ebrei di Bolechow ancora viventi, le domande che fa loro, sono prive di sentimentalismo ma ricche di partecipazione emotiva.
Confronta i nuovi dati che apprende con i dati di cui è già a conoscenza.
A tutti pone la medesima domanda: “Vi ricordate di Shmiel e della sua famiglia?”.
Le risposte sono tante, a volte reticenti, a volte contraddittorie, si tratta di dar forma e senso ad un puzzle, “sistematizzare il sapere”, “ordinare una massa informe di dati […] imporre ordine al caos” per ricostruire un tessuto familiare e con esso, inevitabilmente, anche il destino di una collettività la maggior parte della quale annientata ed i cui pochissimi superstiti sono adesso sparsi per i quattro angoli del mondo.
 Loro, i testimoni diretti (tutti ormai quasi novantenni) delle Atkionen naziste (e ucraine) che tra il 1942 e il 1943 avevano praticamente cancellato la presenza ebraica nel paese d’origine mostrano una grandissima dignità quando guardano vecchie foto per ricordare, risvegliare la memoria per raccontare com’era quel “paese d’altri tempi”.
Loro, i testimoni diretti (tutti ormai quasi novantenni) delle Atkionen naziste (e ucraine) che tra il 1942 e il 1943 avevano praticamente cancellato la presenza ebraica nel paese d’origine mostrano una grandissima dignità quando guardano vecchie foto per ricordare, risvegliare la memoria per raccontare com’era quel “paese d’altri tempi”.
Nel libro ci sono molte immagini. Ci sono le vecchie foto di Schmiel, di sua moglie e delle figlie ma anche di alcuni dei sopravvissuti e ci sono anche le foto scattate da Matt, il fratello di Daniel, ai vari testimoni.
La presenza delle immagini nel testo e del loro ruolo di attivazione della memoria non può, ovviamente, non ricordare Sebald e d’altra parte lo stesso Mendelsohn lo cita, anche se indirettamente.
E poi, si, si, certo, anche a me è venuto subito in mente il Sebald de Gli emigrati...
La somiglianza tra il libro di Mendelsohn e quelli di Sebald però finisce qui, perchè per Mendelsohn il significato delle immagini si collega piuttosto alla grande letteratura classica: “Il significato delle immagini — come possono costituire un divertimento per alcuni, e suscitare una profonda, persino sconvolgente commozione per altri — è il tema di uno dei passi più celebri della letteratura classica. Nell’Eneide, il poema epico di Virgilio che quanti sono sopravvissuti a catastrofiche distruzioni riveste un particolare significato” e ricorda in particolare il passaggio in cui Enea, a Cartagine, si trova davanti un dipinto raffigurante scene della guerra di Troia e ne rimane profondamente turbato: “Per i cartaginesi quel conflitto era semplicemente un motivo decorativo, […] per Enea, naturalmente, riveste ben altro significato e davanti a quella immagine che narra la sua vita scoppia in lacrime”.
Mendelsohn, con una grande sensibilità, comprende che queste immagini che per lui non sono che interessanti, istruttive o al massimo commoventi hanno, per i sopravvissuti “il potere improvviso di ricordare alle persone alle quali le mostravo adesso la vita ed il mondo dal quale erano stati strappati” perchè queste persone sono, a differenza di lui, ebreo di terza generazione, sono “persone […] ricche di memoria ma povere di ricordi”
E gli torna in mente il celeberrimo verso dell’Eneide: “Sunt lacrimae rerum”: ci sono lacrime nelle cose, “ma noi piangiamo tutti per ragioni differenti”.
Una componente originalissima del testo di Mendelsohn (continuo a chiamarlo “testo” perchè mi rifiuto di incasellarlo in un “genere” classificandolo come romanzo, biografia, ricerca storica, raccolta di testimonianze, perchè il libro è tutte queste cose insieme) è il fatto che la storia della ricerca è “accompagnata” dall’inserimento di riflessioni esegetiche su alcuni corposi e fondamentali passi della Torah.
Mendelsohn utilizza questi passi come griglia di lettura per le vicende storiche di cui va narrando e delle tematiche che va esplorando: la Genesi e il Diluvio (creazione —> distruzione, Olocausto —-> rinascita attraverso pochi sopravvissuti), il conflitto/rivalità tra fratelli (Caino ed Abele: perchè il nonno non mandò al fratello rimasto in Europa i soldi per il viaggio in America che avrebbe potuto salvare la vita a lui ed alla sua famiglia?), il viaggio (il viaggio di ricerca di Mendelsohn, il viaggio in America del nonno, il viaggio di emigrazione verso Paesi sconosciuti — Abramo — il viaggio di ritorno in patria — Odisseo), il viaggio in Palestina di un altro dei fratelli del nonno, negli anni ’30, il viaggio/percorso di conoscenza, il viaggio nel tempo passato.
Quello che emerge a poco a poco e in modo sempre più distinto dalla lettura de Gli scomparsi non è soltanto l’individualità di Schmiel Jäger, della moglie Ester e delle figlie Lorka, Frydka, Ruchele e Bronia (di cui all’inizio della ricerca l’autore non conosceva nemmeno i nomi propri) ma i caratteri dei testimoni, la loro personalità, il loro essere accomunati ma anche divisi da un passato comune, il loro non riuscire a prendere emotivamente le distanze dalle terribili esperienze di sessantanni prima che li hanno segnati per sempre (“qualcosa si è spezzato dentro”, è una frase ricorrente) nonostante il radicale cambiamento determinato dall’essere emigrati in paesi, continenti, culture e lingue diverse da quelle di origine.

Gli scomparsi è un libro molto bello e coinvolgente, ricco di storie dentro altre storie: c’è la storia della famiglia di Schmiel, la storia di una comunità (gli ebrei di Bolechow), la storia di una ricerca storica, le storie dei sopravvissuti, le storie di viaggi nel tempo, nello spazio, nella memoria… la storia della attuale famiglia americana di Daniel e del suo rapporto con i propri fratelli…
Certo, occorre una certa attenzione per non perdersi nelle decine e decine di nomi di quasi quattro generazioni (ma in questo aiuta molto l’albero genealogico posto proprio all’inizio del libro) e dei testimoni, nel labirinto delle continue scoperte, smentite, ipotesi, tentativi di verifica delle ipotesi, testimonianze a volte contraddittorie, nella struttura linguistica spiraliforme.
Come tutti i grandi libri, la lettura de Gli scomparsi richiede pazienza ed attenzione, ma il testo di Mendelsohn si legge molto scorrevolmente e l’autore si rivela, pagina dopo pagina, un grande scrittore.
Nella sua ricerca, Mendelsohn si comporta come un detective che vuole sapere, non giudicare.
Non cerca il “perchè” ma il “come”. Più volte nel libro, e in tutte le interviste che ho letto, Mendelsohn ripete di non essere ossessionato dalla Shoah:
“Per me era solo una questione di famiglia, un interesse privato. In fondo volevo scoprire quale fosse stato il destino di zio Schmiel e degli altri” (p.402)
Procedendo in questo modo Mendelsohn si rivela non solo una persona sensibile, delicata, ricca di calore umano, rispettoso degli altri, erudito ma non pedante ma fornisce anche, in realtà, uno spaccato molto realistico e commovente sui massacri della Shoah.
Comprendendo che “Per i lettori è naturalmente più piacevole assimilare il significato di un vasto affresco storico attraverso la storia di una singola famiglia” (p.34) riesce ad innescare in chi legge quel processo di identificazione e di empatia che è indispensabile per potere, se non immedesimarsi, almeno avvicinarsi alla comprensione di un dramma che ha travolto milioni di persone. Non a caso il titolo originale del libro recita “Six of six million”.
Sei milioni è solo un’entità numerica astratta, mentre il racconto dettagliato di come vennero trucidati sei individui dei quali è possibile tratteggiare personalità, piccole abitudini quotidiane (“portava la borsetta in questo modo”, “aveva delle belle gambe”, “teneva la casa come uno specchio”) ci commuove profondamente e contribuisce molto — può sembrare paradossale, ma è così — ad ampliare la nostra conoscenza sulla Shoah nell’Europa orientale, sui rapporti tra ebrei ed ucraini ( “gli ucraini erano i peggiori di tutti” , ripeteva sempre il nonno di Daniel)

Joyce Carol Oates ha ragione quando dice che il libro di Mendelsohn ha molte assonanze con Alla ricerca del tempo perduto di Proust, ed Alessandro Piperno, in un articolo, scrive che Proust sembra essere “il convitato di pietra” del libro. Le frasi lunghe e sinuose di Mendelsohn, nelle quali abbondano gli incisi e le parentetiche, le sue circonvoluzioni, i ritratti di certi personaggi, la grande sensibilità che gli permette di cogliere attraverso mezze parole, uno sguardo, un accenno, i sentimenti non espressi apertamente, inespressi e inesprimibili dei suoi interlocutori.
D’altra parte, che Mendelsohn ponga in qualche modo Proust come una sorta di “nume tutelare” della sua opera lo colgo anche nel fatto che egli sceglie come epigrafi per la parte iniziale (Bereishit, ovvero il principio) e per quello finale (Vayeira, ovvero l’albero nel giardino) della sua opera proprio due frasi di Marcel Proust.
La prima è tratta da La prisonnière:
“Quand nous avons dépassé un certain âge, l’âme de l’enfant que nous fûmes et l’âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais sorts…”
Superata una certa età lo spirito del bambino che era in noi e le anime dei nostri defunti profondono ricchezze e incantesimi su di noi…”
La seconda è tratta da À l’ombre des jeunes filles en fleur:
“c’est que dans l’état d’esprit où l’on «observe», on est très au-dessous du niveau où l’on se trouve quand on crée.”
“…la condizione mentale di chi “osserva” è di gran lunga inferiore a quella di chi crea”
Pubblicato per la prima volta nel 2006, Gli scomparsi ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo ed ha già collezionato un notevole numero di premi: il National Book Critics’ Circle Award, il National Jewish Book Award, il Salon Book Award, l’ American Library Association Medal for Outstanding Contribution to Jewish Literature ed in Francia il Prix Médicis Etranger, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a scrittori stranieri.
Qualche link di approfondimento
- Colloquio di Alessandro Piperno con Daniel Mendelsohn >>
- The Mendelsohn Family’s Bolekhov Website, il sito su Bolechow realizzato da Andrew Mendelshon, fratello maggiore di Daniel
- Intervista a D. M. (in inglese) >>
- Su YouTube, una discussione tra Padre Patrick Desbois e Daniel Mendelsohn su la Shoah in Ucraina (Fnac Ternes, 16 gennaio 2008. In francese) Prima parte e Seconda parte
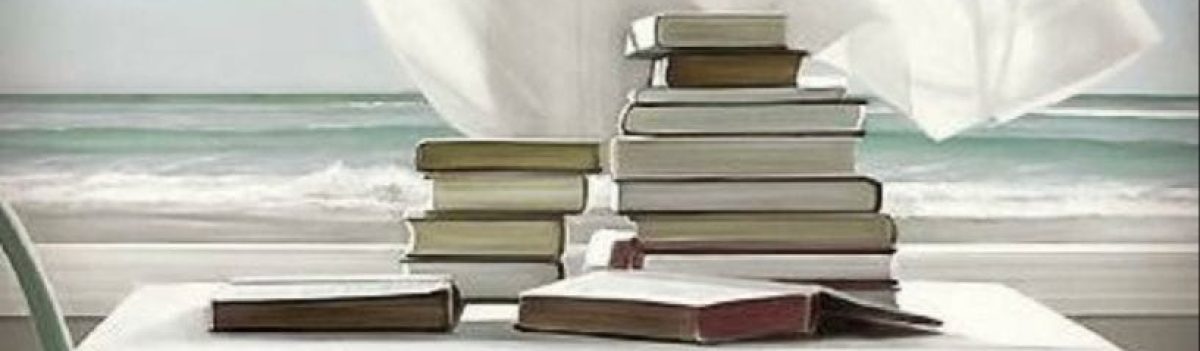



se già ero incuriosita, adesso non vedo l’ora di iniziarlo!
molto interessanti queste tue considerazioni sull’inclassificabilità di tale testo e sul tentativo riuscito di M. di creare un testo letterario, indagando non tanto sul perché ma sul come. Mi hanno fatto venire subito in mente Hilsenrath che, a mio avviso, con la sua "La fiaba dell’ultimo pensiero" tenta (e ci riesce alla grande) un simile approccio.
E come non tirare delle parallele con Reitz: ancora una volta anche se con contesti diversi ci viene data la possibilità di immedesimazione focalizzando il testo/racconto/sceneggiatura su una famiglia. Non so perché associo poi a Goethe il pensiero che mi colpì quando lo lessi per la prima volta che la scintilla della com – passione (ovvero la possibilità di empatia e immedesimazione) può scoccare solo nel momento in cui un’entità numerica astratta diventa una "famiglia".(ovviamente il ricordo è molto liberamente associato a Goethe, ma poi non è certo un pensiero espresso solo da lui se mai la mia memoria non m’ingannasse)
Grazie, Gabriella. di questa ennesima interessantissima "recensione"!
"Mi piace""Mi piace"
Mi associo a Stephi: se già mi avevi indotto alla curiosità ora il mio interesse è certo. Sarà sicuramente il mio prossimo acquisto e forse la mia prossima lettura, anche se sul comodino mi attende già Suttree di McCarthy e stavo procedendo alla lettura del Porto di Toledo della Ortese (intervallato però da altro: non riesce ancora a prendermi come aveva fatto il ‘Cardillo’).
Invece Zafòn (Marina) potrà sicuramente attendere.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Gabriella, per la tua interessantissima segnalazione. Penso che acquisterò il testo, al quale in un certo modo sto girando intorno: ho infatti intrapreso la lettura di "Yan Karski" di Yannick Haenel – la storia del polacco che si recò nel 1942 da Roosvelt per informarlo dello sterminio degli ebrei polacchi ed europei – e, in parallelo, "Lenove porte" di Jiri Langer, documento e testimonianza delle comunità chassidiche dell’Europa orientale, spazzate via dal nazismo. Anche questi due libri difficile da classificare quanto a genere.
A presto. Paola.
"Mi piace""Mi piace"
Dopo questa tua presentazione, veramente coinvolgente, non resta che procurarsi il libro.
Elisabetta
"Mi piace""Mi piace"
Stephi, Hinselrath mi manca, so che è un grossa lacuna ma non credo che avrò lo stomaco per leggere/reggere La fiaba dell’ultimo pensiero… Vedremo…
carloesse ed Elisabetta
Mi fa piacere se sono riuscita in qualche modo a trasmettere il grande coinvolgimento che mi ha procurato questo libro…
Paola
il libro di Haenel mi interessa molto. Potrei leggerlo in francese, ma siccome per quel che ne so dovrebbe arrivare presto in Italia edito da Guanda, e siccome non mi manca certo di che leggere, nel frattempo… tanto vale per me aspettarlo in italiano.
Non sono sicura invece di essere interessata a Le nove porte… Non sono proprio sicura che mi interessi più di tanto addentrarmi nei meandri del chassidismo… Ma probabilmente sbaglio. Vorrei almeno prendere in mano il volume. sfogliarlo e… "annusarlo", prima di decidere.
Ciao e grazie
Per tutte/i
mi farebbe molto piacere, se doveste decidere di leggere questo libro, voleste poi condividere qui le vostre impressioni ed integrare la mia "lettura".
"Mi piace""Mi piace"
Intanto l’ho comprato e ho assaporato le prime pagine. Credo continuerò, lasciando in sospeso le altre letture iniziate o programmate. In fondo mi succede spesso così.
"Mi piace""Mi piace"
Carloesse
Attendo speranzosa
Ciao!
"Mi piace""Mi piace"
Più o meno nello stesso periodo ho letto questo libro, quello di Helga Shneider (lLasciami andare, madre), e la Storia naturale della distruzione di Sebald., tre libri di cui tu hai già parlato qui, che trattano di uno stesso periodo e in fondo dello stesso tema: la memoria.
Sono tre libri interessantissimi, belli, duri e incisivi, di quelli che lasciano il segno.
Quello di Mendelssohn è il più corposo, ma in fondo il più "facile" da leggere: appassionante quanto un romanzo (se lo sia o no è secondario), in fondo è un puzzle da ricostruire attraverso le ultime possibili testimonianze, prima che possano sparire per sempre. Mendelsshon tra i tre è lo scrittore meno direttamente coinvolto (è un ebreo-americano quasi da tre generazioni) e nonostante la sua passione filologica questo lo si avverte nettamente nel confronto (senza voler esprimere con ciò alcun "giudizio di valore", che reputo molto alto anche per questo libro, anzi forse il più bello tra i tre proprio per questa sua maggiore "facilità").
Quello della Shneider è invece già di per sè una testimonianza (anche se necessita anch’esso di un’altra testimonianza, per ricostruire la memoria e comprendere sino a fondo una realtà fino allora puramente emotiva), ed un’indagine tra i sentimenti di chi lo scrive ed ha vissuto in prima persona la sofferenza di essere figlia di una madre mancata al suo ruolo, travolta dalla follia dell’epoca.
Quello di Sebald è un’analisi sulla rimozione di massa della memoria di un popolo sconfitto, che in fondo rifiuta di interrogarsi sul perchè di una così immane tragedia, da esso provocata, ed infine da esso stesso anche subita, in una sorta di contrapasso.
Ma è la concomitanza di queste tre letture che mi ha colpito. E in fondo mi ha anche fatto comprendere più profondamente il senso della memoria e l’importanza delle immagini (che forse avevo già intuito, ma non profondamente capito) , vera nota distintiva nei romanzi di quello dei tre autori che in fondo maggiormente mi interessa, considerandolo uno dei massimi scrittori contemporanei: W. G. Sebald.
E poi, parlando di memoria, non si può mai naturalmente non ritornare a Proust (ma di questo hai già parlato tu).
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
carloesse
Hai citato tre libri bellissimi, tre esperienze completamente diverse, tre punti di osservazione e tre modi di essere vicini/distanti dall’oggetto della memoria altrettanto diversi.
Non mi posso soffermare nel dettaglio di quanto scrivi, ti dico solo che complessivamente condivido.
Da parte mia aggiungo solo che su queste tematiche terrei presente anche l’ottimo "La casa dei bambini dimenticati" di Owen Matthews di cui ho parlato qui poco tempo fa.
Le analogie e le differenze di cui parli a proposito degli altri tre autori ci sono tutte (anche se l’esperienza di Matthews mi pare più affine a quella di Mendelsohn, essendo anche lui di terza generazione rispetto ai nonni perseguitati).
E poi, ho letto che nell’edizione originale inglese ci sono le fotografie dei familiari di Matthews, però non avendo visto il libro, non posso dire che tipo di funzione abbiano le immagini in quel testo, probabilmente solo illustrativa da "album di famiglia", chissà.
Ultima veloce notazione: credo che questo filone del recupero della memoria da parte delle "terze generazioni" sia importante e da tenere d’occhio per almeno tre motivi:
* il primo è quello di cui parla anche Mendelsohn, e cioè il fatto che questa generazione è l’ultima ad avere la possibilità di ascoltare la testimonianza diretta dei sopravvissuti i quali, per ovvie ragioni anagrafiche scompariranno, tra non molto, tutti.
* il secondo è che lo spostamento/allontanamento del punto di vista di chi alcune cose le ha vissute direttamente e di chi, pur essendo legato da parentele e affetti alle vittime, vivendo in un’epoca ed in un contesto completamente — per fortuna! — diverso, fa una gran fatica a immedesimarsi davvero nel racconto di quelle atrocità e ad andare oltre la com-prensione razionale mi sembra un elemento importante e molto interessante.
Anche di questo parla Mendelsohn, e secondo me lo fa in modo eccellente, oltre che profondamente onesto.
* terzo motivo (che è conseguente ai primi due) è che il racconto di questi parenti di terza generazione ha una funzione veicolante e delicatissima di "filtro".
Personalmente mi auguro che libri di questo tipo se ne scrivano molti, e nello stesso tempo mi auguro che siano scritti se non con oggettività (l’oggettività non esiste) con onestà intellettuale e sincerità affettiva.
Ciao e grazie! 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Grazie a te.
Quanto al libro di Matthews avevo già adocchiato qui il tuo post, e non ti nascondo che già mi aveva incurisito. Credo lo leggerò a breve.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Gabrilù, lo sto leggendo ora e la prima impressione conferma in pieno quanto scrivi, inclusa la benedizione di Proust. Non è facile, soprattutto i passaggi sull'interpretazione dei testi biblici (Rashi ecc) ma è ricco di innumerevoli spunti – anche sul mestiere di scrivere, oltre che sul significato della memoria. Ci aggiorniamo quando lo finisco. Bacivera – panchinedimilano
"Mi piace""Mi piace"
Vera-panchinedimilanoSono molto contenta che tu stia apprezzando come merita questo libro bellissimo.Se poi ne scrivi sul tuo blog fammi un fischio, qualora dovesse sfuggirmi.Ciao 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Buongiorno Gabrilu
ho letto “gli scomparsi” seguendo il tuo blog e l’ho trovato appassionante quanto un libro giallo.
grazie sempre per le tue preziose segnalazioni.
un abbraccio ideale
Vania
"Mi piace""Mi piace"
vania grazie a te…
"Mi piace""Mi piace"